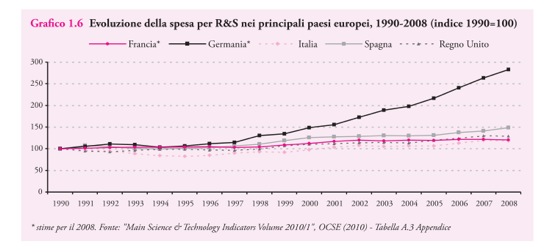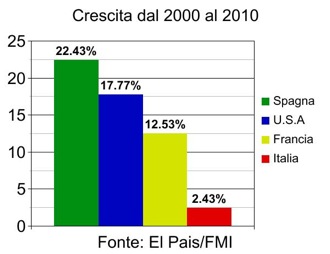Giovanilismo e rottamazione
Se Berlusconi non ride (perlomeno sino al 15 dicembre) la sinistra di Bersani e dintorni può solo piangere. Quando il Pd era il Pc—da Togliatti a Berlinguer — il cursus honorum, la carriera, era rigidamente disciplinata: prima una esperienza nelle amministrazioni locali, poi, per i più bravi, il parlamento nazionale. Il tutto era deciso dalla segreteria del partito e, in ultima istanza, dal suo segretario. Allora nessuno osava dire, e nemmeno pensare, che i Pajetta e i Terracini di quel tempo fossero da «rottamare», da pensionare perché vecchi. E se Togliatti non fosse deceduto anzitempo, nessuno lo avrebbe contestato nemmeno a 90 anni. Eppure quel Pc, nel complesso «anzianotto», arrivò a conseguire un terzo del voto degli italiani e quasi a sorpassare la Dc.
Rispetto alla sua epoca d’oro la nostra sinistra post-comunista di oggi esibisce leader relativamente giovani, da D’Alema a Fassino a Veltroni e Bersani. Nessun vegliardo. Eppure il sindaco di Firenze Matteo Renzi (35 anni) e il governatore della Puglia Vendola (52 anni) li definiscono «roba vecchia», materiale da pensione. La loro parola d’ordine è avanti i giovani, e cioè sé stessi. Nella storia, da sempre e dappertutto, il giovanilismo è raro. Le irrequietezze giovanili cominciano con lo Sturm und Drang (tempesta e assalto) dei primi romantici e, in Italia, con il futurismo e il fascismo. Ma furono fuochi fatui. Le rivoluzioni sono spesso promosse dai giovani; giovani che però si attaccano al potere sino alla morte. Quando l’Urss si dissolse esibiva la più straordinaria gerontocrazia (governo dei vecchi) al mondo.
Dicevo che il giovanilismo non dura. È così per forza, perché i giovani diventano vecchi. Ma è anche bene che sia così. I giovani apportano un elemento — l’energia — che gli anziani non hanno più, mentre gli anziani apportano l’elemento che i giovani ancora non hanno, e cioè esperienza e conoscenze. Insomma, gioventù è energia senza sapere, anzianità è sapere senza energia. Le civiltà decadono per senescenza e quando diventano gerontocrazia. Però, nessuna civiltà è mai emersa da una paidocrazia, dal potere dei giovani.